Hai mai pensato che una routine possa ridurre l’ansia? Cosa dicono davvero le neuroscienze.
- Cristina Moro
- 13 nov 2025
- Tempo di lettura: 4 min
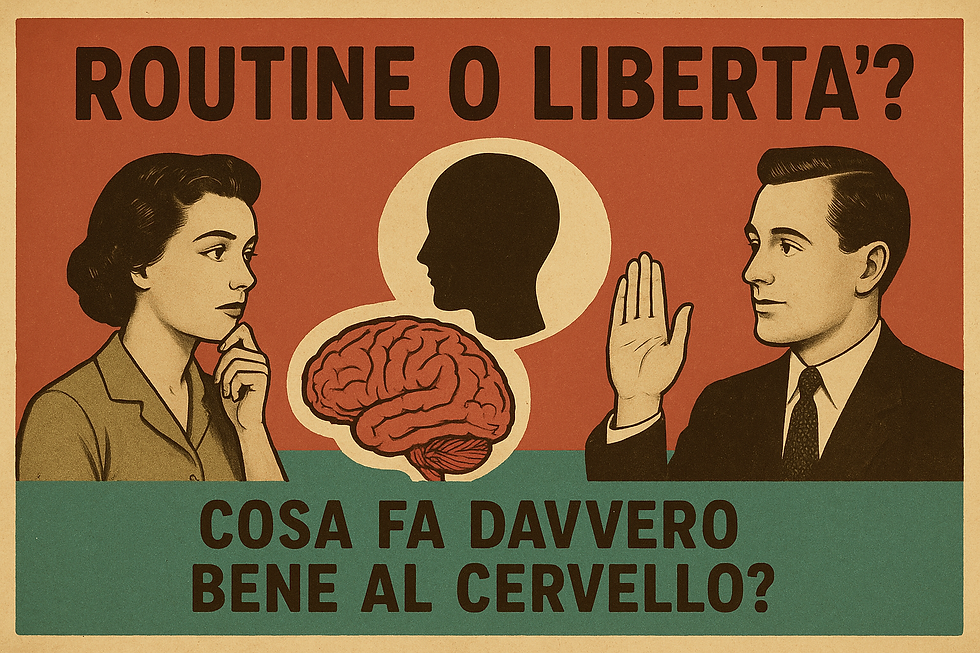
A volte ci diciamo che “avere una routine” ci farà sentire più tranquilli, ma poi ci scopriamo intrappolati tra il bisogno di controllo e la paura di perdere la spontaneità.
Ti è mai capitato di sentirti ansioso proprio quando tutto sembra troppo rigido o troppo caotico?
Molte persone si chiedono se la mancanza di routine sia la causa della loro ansia — o se, al contrario, la rigidità delle abitudini le stia imprigionando.
Ma cosa dice davvero la ricerca scientifica? È vero che avere una routine aiuta a regolare le emozioni e a ridurre l’ansia? In questo articolo analizziamo la questione a partire dalle più recenti evidenze neuroscientifiche.
1. La prospettiva psicologica e neurocientifica
La routine, quando è flessibile e significativa, contribuisce alla stabilità del sistema nervoso. Il cervello umano cerca prevedibilità: sapere cosa accadrà in un tempo prossimo riduce il carico cognitivo e l’attivazione limbica legata alla minaccia (Schulkin & Sterling, 2019).
Le neuroscienze mostrano che la regolarità dei comportamenti quotidiani — come orari del sonno, pasti e attività — migliora la connettività tra la corteccia prefrontale e l’amigdala, due aree chiave nella regolazione emotiva (Patriquin et al., 2022).In pratica, una routine coerente aiuta il cervello a passare più facilmente da stati di allerta a stati di calma.
Tuttavia, non è la routine in sé a essere terapeutica, ma il modo in cui la viviamo. Quando diventa rigida, può attivare le stesse aree cerebrali associate all’ansia anticipatoria, mantenendo un alto livello di cortisolo e ipervigilanza (Cisler et al., 2020).
2. Evidenza scientifica: cosa dicono gli studi
Diversi studi recenti confermano che una struttura quotidiana regolare è associata a un miglior benessere psicologico e minori livelli di ansia.
Un metanalisi pubblicata su BMC Psychiatry (2023) ha mostrato che la disorganizzazione nei ritmi circadiani è significativamente correlata a un aumento dei sintomi ansiosi e depressivi. Allo stesso tempo, uno studio longitudinale su 2.000 adulti (Lyall et al., 2018) ha evidenziato che mantenere ritmi regolari di sonno e attività favorisce una maggiore resilienza allo stress e migliori capacità di autoregolazione emotiva.
Tuttavia, alcuni autori invitano alla cautela: una routine eccessivamente rigida può ridurre la flessibilità psicologica e compromettere la capacità di adattamento.
Ad esempio, uno studio di Hou et al. (2021) ha evidenziato che la flessibilità regolatoria — ossia la capacità di modificare le proprie abitudini in funzione dei bisogni emotivi del momento — nel mantenere routine quotidiane è inversamente associata a sintomi di ansia e depressione in condizioni di stress (Bonanno & Burton, 2013).
3. Applicazione terapeutica nella psicoterapia integrativa
In psicoterapia integrativa, il lavoro non consiste nel creare abitudini in modo meccanico, ma nel comprendere come ciascuno vive interiormente la propria routine. Attraverso il percorso terapeutico si esplorano tre livelli di informazione dell’esperienza: corpo, emozioni e pensieri.
A livello corporeo, si osserva come il corpo reagisce di fronte alla prevedibilità o all’imprevisto: tensione, chiusura, respiro trattenuto o, al contrario, rilassamento e apertura. Queste risposte fisiologiche ci parlano del nostro modo di regolare la sicurezza interna.
Sul piano emotivo, si dà spazio a ciò che la routine evoca: tranquillità, noia, senso di controllo o paura di perderlo. Comprendere queste emozioni aiuta a riconoscere come il bisogno di struttura si è costruito nella propria storia e quali aspetti oggi chiedono flessibilità.
Infine, a livello cognitivo, si esplorano i pensieri che accompagnano la quotidianità: le aspettative, le auto-imposizioni, la voce interiore che giudica o rassicura. Quando corpo, emozioni e pensieri iniziano a dialogare, la routine perde la sua rigidità e diventa una forma di autoregolazione consapevole.
Così, la persona impara a costruire una struttura che sostiene, invece di limitare: un ritmo personale che favorisce equilibrio, presenza e benessere emotivo duraturo.
4. Routine e vita di coppia
La qualità delle routine condivise incide anche sulla regolazione emotiva di coppia. Studi sul sincronismo quotidiano mostrano che le coppie che mantengono ritmi coordinati (come orari di sonno simili o rituali condivisi) riportano maggiore soddisfazione e minore conflittualità (Hasler & Troxel, 2020).
La routine diventa un linguaggio relazionale implicito: ciò che si ripete costruisce sicurezza, ma anche identità condivisa. In terapia di coppia, esplorare come ciascun partner vive la struttura comune — se come sostegno o come vincolo — permette di riequilibrare le dinamiche di autonomia e connessione.
5. Consigli pratici e riflessioni terapeutiche
Non esiste una “routine perfetta”, ma una routine coerente con il proprio stato interno. Alcune domande che possono aiutarti a riflettere:
Quando seguo la mia routine, mi sento più libero o più intrappolato?
Quale parte di me ha bisogno di controllo, e quale desidera spontaneità?
Cosa succede nel mio corpo quando cambio i miei ritmi abituali?
Spesso non è la mancanza di organizzazione a generare ansia, ma l’assenza di connessione tra quello che facciamo e come ci sentiamo. Una buona routine nasce da dentro, non da un’agenda.
Conclusione
La scienza conferma che la struttura quotidiana può essere un potente strumento di regolazione emotiva, ma solo quando è flessibile e integrata al nostro vissuto corporeo ed emotivo.In terapia, impariamo a trasformare la routine da strategia di controllo a spazio di cura e sicurezza interiore.
Se senti che le tue abitudini, emozioni o relazioni sono diventate difficili da gestire, in psicoterapia integrativa possiamo esplorare insieme come ricostruire equilibrio e benessere.
Psicoterapia individuale e di coppia a Barcellona o in modalità online con Cristina Moro, psicologa italiana e terapeuta integrativa.
Bibliografia
Bonanno, G. A., & Burton, C. L. (2013). Regulatory flexibility: An individual differences perspective on coping and emotion regulation. Perspectives on Psychological Science, 8(6), 591–612.
Cisler, J. M., et al. (2020). Neurobiological mechanisms of anxiety disorders. Nature Human Behaviour, 4(2), 200–210.
Hasler, B. P., & Troxel, W. M. (2020). Couples’ sleep-wake concordance and relationship satisfaction. Journal of Family Psychology, 34(1), 61–70.
Hou, W. K., et al. (2021). Regulatory flexibility of sustaining daily routines and mental health in adaptation to financial strain: A vignette approach. Frontiers in Psychology, 12, 645.
Lyall, L. M., et al. (2018). Association of disrupted circadian rhythmicity with mood disorders. The Lancet Psychiatry, 5(6), 507–514.
Patriquin, M. A., et al. (2022). Daily routines and emotional regulation: Neural correlates of predictability. Frontiers in Human Neuroscience, 16, 987456.
Schulkin, J., & Sterling, P. (2019). Allostasis: A brain-centered, predictive mode of physiological regulation. Trends in Neurosciences, 42(10), 740–752.


