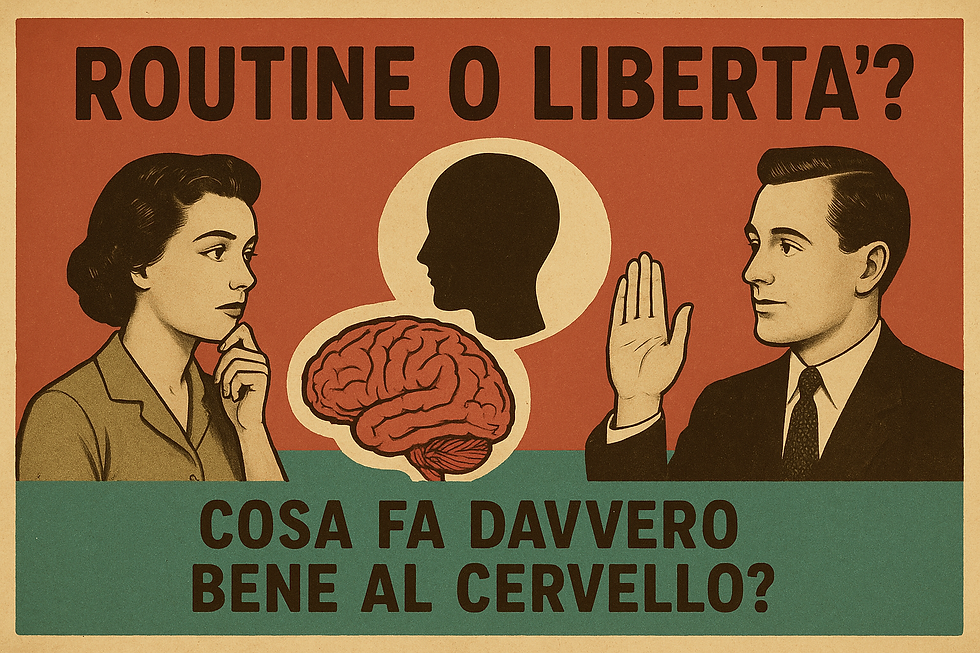Psicoterapia e lingua: meglio parlare nella propria lingua madre o in una seconda lingua?
- Cristina Moro
- 18 set 2025
- Tempo di lettura: 3 min
Aggiornamento: 23 set 2025
Molte persone si chiedono se sia davvero importante fare psicoterapia nella propria lingua madre. Quando si vive all’estero o si parla con un terapeuta di un’altra nazionalità, il dubbio sorge spontaneo: la lingua che uso in terapia può influire sul mio percorso?
La risposta della ricerca è: sì, e molto più di quanto immaginiamo.
La lingua che utilizziamo in psicoterapia non è un dettaglio secondario: influenza emozioni, ricordi e persino il modo in cui il cervello processa le esperienze.
Perché la lingua madre è così importante in psicoterapia?
La ricerca ha dimostrato che le parole nella lingua madre (L1) attivano più intensamente le aree cerebrali legate alla memoria autobiografica e alle emozioni rispetto a una seconda lingua (L2) (Harris, 2004; Pavlenko, 2017). Questo significa che parlare nella propria lingua nativa favorisce una maggiore connessione emotiva e autenticità nell’espressione.
Il cervello elabora le emozioni in modo diverso a seconda della lingua?
Sì. Studi di neuropsicologia mostrano che l’elaborazione di stimoli emotivi è più immediata e intensa in L1. Brase e Mani (2017) hanno osservato che parole emotivamente connotate in lingua madre attivano risposte fisiologiche più forti, mentre in L2 vi è un maggior coinvolgimento delle aree legate al controllo cognitivo. Questo conferma che il cervello “vive” diversamente le emozioni a seconda dell’idioma.
Parlare in una lingua straniera riduce davvero l’intensità emotiva?
Diversi studi confermano che usare una seconda lingua può agire come “filtro protettivo”. Ad esempio, Ortigosa-Beltrán et al. (2023) hanno mostrato che persone che descrivevano esperienze traumatiche in L2 riportavano minore reattività emotiva e meno sintomi da stress post-traumatico. Questa distanza emotiva può aiutare alcuni pazienti ad affrontare ricordi dolorosi con meno sopraffazione.
Cosa succede se i ricordi dolorosi sono legati alla mia lingua materna?
Quando i traumi sono fortemente ancorati alla lingua nativa, raccontarli in quella lingua può risultare troppo intenso. Alcuni terapeuti, in approcci come l’EMDR, hanno osservato che alternare lingua madre e seconda lingua permette di dosare l’intensità dell’elaborazione (Journal of EMDR Practice and Research, 2021). Ciò dimostra che la scelta linguistica può diventare un vero strumento clinico.
Posso cambiare lingua durante la psicoterapia?
Non solo è possibile, ma può essere utile. La terapia bilingue permette di usare la L1 per accedere a ricordi profondi e simbolici, e la L2 per prendere distanza quando l’emozione diventa troppo forte (Karp & Vögele, 2016). La flessibilità linguistica diventa così una risorsa terapeutica.
Quali sono i vantaggi e gli svantaggi della terapia bilingue?
Vantaggi L1: espressione più ricca, connessione emotiva, accesso ai ricordi d’infanzia.
Svantaggi L1: rischio di riattivazione troppo intensa di traumi.
Vantaggi L2: maggiore controllo cognitivo, distanza protettiva, facilità nel trattare contenuti dolorosi.
Svantaggi L2: minore spontaneità emotiva, possibile senso di estraneità.
La letteratura concorda sul fatto che nessuna lingua è intrinsecamente “migliore”: dipende dalla storia del paziente e dagli obiettivi terapeutici (Costa et al., 2017).
Il linguaggio influisce sulla relazione con il terapeuta?
Sì. Parlare la stessa lingua madre del terapeuta può facilitare l’empatia e il senso di vicinanza (Santiago-Delefosse et al., 2015). Tuttavia, la relazione terapeutica non dipende solo dalla lingua, ma soprattutto dalla qualità dell’ascolto e della presenza del terapeuta. Alcuni pazienti riferiscono che usare una lingua diversa dalla madre riduce l’imbarazzo e facilita la rivelazione di contenuti intimi (Dewaele, 2010).
Come scegliere l’idioma giusto per il proprio percorso di psicoterapia?
La scelta della lingua in terapia non è neutra. La ricerca dimostra che:
la lingua madre favorisce profondità emotiva e autenticità,
la seconda lingua può ridurre l’impatto del dolore e favorire la regolazione emotiva.
La decisione migliore dipende dalla storia del paziente, dal livello di padronanza linguistica e dal tipo di terapia. In molti casi, alternare entrambe le lingue rappresenta la soluzione più efficace.
Bibliografia
Brase, G., & Mani, N. (2017). Processing emotional language: insights from bilingualism. Cognition and Emotion.
Costa, A., Foucart, A., & Hayakawa, S. (2017). Emotion regulation in a foreign language. Psychological Science.
Harris, C. (2004). Bilingual speakers’ emotional responses in L1 and L2. Journal of Multilingual and Multicultural Development.
Karp, D., & Vögele, C. (2016). Emotional expression in bilingual therapy. Psychotherapy Research.
Ortigosa-Beltrán, A., et al. (2023). Trauma narratives in a foreign language. Frontiers in Psychology.
Pavlenko, A. (2017). The Bilingual Mind. Cambridge University Press.
Santiago-Delefosse, M., et al. (2015). Language and therapeutic alliance. European Journal of Psychotherapy & Counselling.
Journal of EMDR Practice and Research (2021). Case reports on bilingual EMDR.